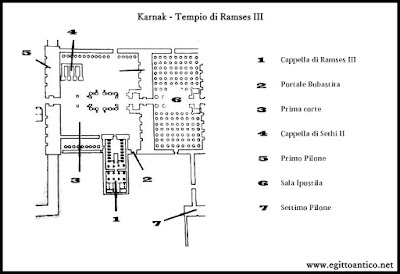Le necropoli degli animali, situate nella zona settentrionale di Saqqara, costituiscono uno dei grandi complessi di questo sito, ricco di monumenti storici. In un settore chiamato "Hap-neb-es", che significa "colui che nasconde il suo signore", si trovano l'Anubeion, dedicato al dio dalla testa di sciacallo Anubi, e il Bubasteion, dedicato alla dea gatta Bastet.
Sebbene situati l'uno accanto all'altro, l'Anubeion e il Bubasteion costituiscono due necropoli distinte, a est della piana di Ankhtauy, nome dato alla zona delle necropoli degli animali a Saqqara. A ciascuno dei due templi sono associate catacombe destinate alla sepoltura di cani per l'Anubeion e di gatti per il Bubasteion. costruito su un rilievo, l'Anubeion, la "casa del baule di Anubi" costituisce il punto culminante ove il dio dalla testa di cane o di sciacallo (il celebre Tepy-Giuef, cioè "Anubi che sta sulla montagna") si trovava al confine tra due mondi: l'ambiente ostile del deserto e il paesaggio idilliaco della vallata. Infatti il cane, ritenuto dagli egizi un animale in grado di muoversi senza difficoltà tra questi due mondi distinti, ma anche all'interno di ciascuno di essi, era il simbolo di colui che intercede, dell'intermediario. Anubi era quindi il protettore di tutta la necropoli di Saqqara, la sentinella che vegliava sul riposo eterno dei faraoni che avevano fatto costruire la loro ultima dimora nel sito a lui consacrato.
L'Anubeion
Costruito sulle rovine del tempo funerario del re Teti I, faraone della VI dinastia, l'Anubeion è circondato da un muro di cinta attraverso il quale passa un dromos che conduce al Serapeo in cui sono sepolti i tori Hapi. Probabilmente questo stesso percorso rituale veniva anche utilizzato dalle due comunità di sacerdoti, quelli di Anubi e quelli di Hapi, dal momento che i testi del Serapeo fanno spesso menzione dello Uabet (il laboratorio di imbalsamazione di Menfi) presso Anubi, l'imbalsamatore. Grazie a un'apertura potevano raggiungere il vicino Bubasteion per mezzo di una strada lastricata. In questi luoghi, il rito di Anubi risale alla più remota antichità egizia, poiché si possono enumerare non meno di sette fasi costruzione, dall'Antico Regno fino all'era cristiana. I muri alti e la posizione elevata del sito, costruito a terrazze che si affacciano sulla piana di Saqqara, hanno permesso per secoli alle popolazioni che si sono succedute all'interno del muro di cinta di premunirsi contro eventuali attacchi esterni. Questo insieme funerario di primo piano doveva essere assi vasto, dal momento che l'archeologo Quibell, nel corso degli scavi intrapresi all'inizio del XX secolo, vi scoprì diverse camere funerarie consacrate a Bes, una divinità popolare. Quanto al tempio di Anubi propriamente detto, è stato eretto contro il muretto della seconda terrazza. I visitatori vi accedevano attraverso due cortili a peristilio, a partire da una scarpata in salita, e i sacerdoti potevano salire sulla terrazza superiore per mezzo di un scala. Sul secondo terrapieno di trovano i magazzini del tempio. Poiché si trattava di un complesso funerario dedicato agli animali, le catacombe con le mummie dei cani non si trovavano sul sito dell'Anubeion, ma un po' più a nord, e si presentano come due gallerie piuttosto lunghe: i cani mummificati erano sepolti da una parte e dall'altra della galleria principale, entro corridoi laterali.
Il Bubasteion
Separato dall'Anubeion da un corridoio fiancheggiante il muro di cinta delle due necropoli, il Bubasteion era la dimora di Bastet, la dea dalla testa di gatto, signora di Bubastis. Agli occhi degli antichi egizi, Bastet, come Anubi, vigilava sulle località prossime al deserto. Divenuta protettrice della necropoli generale di Saqqara, si faceva garante, con il supporto di Anubi, della sua pace e della sua serenità. A sud del Bubasteion si estendeva un lago sacro. Si suppone che il tempio dedicato a Bastet si elevasse sulla parte rocciosa, ma oggi non ne rimane alcuna traccia. Come l'Anubeion, anche il sito funerario del Bubasteion è circondato da una recinzione, ma quest'ultima è più piccola rispetto a quella del suo prestigioso vicino. Una porta colossale si apre sul sito a sud, mentre un'altra porta assiale, tagliata nel muro di cinta, si affaccia sull'Anubeion. La cinta protegge le catacombe dei fatti, chiamate "casa di riposo dei gatti". Vi è stata ritrovata una grande quantità di mummie di felini risalenti all'epoca tolemaica, quando ormai non era più valida la norma secondo la quale anche una semplice ferita inferta ad un gatto poteva essere punita con percosse corporali.